ROMA – Una frase. Mai come nel caso de Le Ali della Libertà si può dire che un intero film può essere racchiuso in una sola frase. Quella che preannuncia il finale e la sua esplosione emozionale e di cui ascoltiamo le parole con la voce del Red interpretato da Morgan Freeman: «O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. E io ho scelto di vivere». Una frase che in realtà sentiamo pronunciare due volte lungo il corso della pellicola e in momenti di differente inerzia. La prima volta, infatti, la dice Andy Dufresne (Tim Robbins) rivolgendosi a Red – dentro le mura di Shawshank – mentre sogna a occhi aperti una vita felice e libera fuori da quelle mura istituzionalizzate. A Zihuatanejo per la precisione, in Messico, un posto caldo e senza memoria. Un posto di vita semplice dove tutto ciò che alberga nel cuore può realizzarsi.

È un sogno, però, quello di Andy. Ci metterà poco a compiersi, è vero – il film lo conosciamo tutti del resto –, ma in quella frase detta in quel particolare momento di Le Ali della Libertà c’è tutta la vita, la voglia di speranza e di vedere i propri desideri realizzarsi gettandosi nell’ignoto. C’è tutto, tutto quello di cui un uomo ha bisogno, ma è sempre nel campo delle ipotesi quello in cui ci muoviamo, di desideri fondati. Non la seconda volta, però. Perché lì, invece, Red vede la sua vita aprirsi verso un futuro altrimenti impossibile dentro le mura di Shawshank. Un futuro da uomo libero e felice che non vede l’ora di riabbracciare qualcuno che non vede da troppo tempo. Lo diciamo, perché è esattamente questo ciò che ha fatto il prodotto filmico Le Ali della Libertà lungo il suo retaggio trentennale.

Da quel 14 ottobre 1994 che vide il film di Frank Darabont approdare nelle sale statunitensi, infatti, Le Ali della Libertà ha fatto di tutto per vivere e per consacrarsi nell’immaginario collettivo. Certo, fa un po’ strano sentirne parlare così oggi, anche stando alle parole dello stesso Robbins: «Giuro su Dio, in tutto il mondo, in tutto il mondo, ovunque io vada, ci sono persone che dicono: Quel film mi ha cambiato la vita». Non a caso su Imdb, il più grande database cinematografico al mondo, risulta essere il film più votato di sempre piazzandosi in cima nella classifica dei migliori 250 film secondo il portale (poi Il Padrino e Il Cavaliere Oscuro). Un capolavoro assoluto insomma, un cult inarrestabile, o quasi. Perché all’epoca, nel 1994, fu praticamente accolto come una barzelletta il film di Darabont, in particolare da una certa fetta di critica oltreoceano.

Alcuni test-screening con Darabont e l’executive Liz Glotzer di Castle Rock presenti in sala diedero risultati brillanti. Ragion per cui si decise di omettere il nome di Stephen King autore del (quasi) omonimo racconto originario (Rita Hayworth e la Redenzione di Shawshank della raccolta Stagioni diverse del 1982) dal materiale pubblicitario in modo da giocare con le aspettative del pubblico ed evitare che Le Ali della Libertà venisse accostato a flop commerciali (ma grandi film) come Shining e Cujo. Dopo una buona accoglienza al Toronto International Film Festival, la Castle Rock decise di distribuirlo in forma limitata nel terzo weekend di settembre nelle sale statunitensi. Il risultato? Distribuito in 33 sale il 23 settembre, il film incassò appena 727.000 dollari. In particolare nella zona di Los Angeles dove una fetta di pubblico fu influenzata da una recensione poco lusinghiera di Kenneth Turan del L.A. Times.

Il critico, infatti, definì Le Ali della Libertà come un solido film dal trattamento dubbio a causa di alcune svolte narrative incoerenti. Debolezze che in verità, trent’anni dopo, hanno contribuito a rendere quello di Darabont un film magico, libero e puro in tutte le sue sfumature. Non al tempo però. A fronte di un budget di 25 milioni di dollari messo in dote da Castle Rock e Columbia Pictures, Le Ali della Libertà concluse la sua corsa al box-office con un incasso di appena 16 milioni di dollari: un fiasco commerciale su tutta la linea. Freeman se la prese con il titolo scelto. Robbins gli fece eco, ma in modo più ironico: «All’epoca la gente mi fermava per strada chiedendomi che film fosse The Shinkshonk Reduction». In verità furono anche proposti diversi titoli per il film, ma nessuno di questi risultava appetibile per un prison movie di quella densità.

A un certo punto, in pre-produzione, si pensò perfino di utilizzare il nome del racconto originario così da includervi Rita Hayworth, ma il timore era che alcuni potessero fraintendere Le Ali della Libertà come un fantomatico biopic sull’attrice di Gilda (non a caso citata graficamente anche se nel romanzo il film della sequenza è Giorni Perduti nda). Timore fondato visto che, quando si sparse la voce che la Columbia Pictures mise in cantiere l’adattamento del racconto kinghiano, diverse attrici e supermodelle si proposero tramite i loro agenti di spettacolo per interpretare quello che credevano sarebbe stato il ruolo principale. Non era niente di tutto questo ovviamente, solo una storia carceraria come quelle che affascinarono King da bambino. Il flop di Le Ali della Libertà va semplicemente ricercato in ragioni altre che esulano la caratura artistica del film, la natura dell’adattamento o la mano registica di Darabont.

In quelle stesse settimane al cinema c’erano Forrest Gump, Pulp Fiction e in minor misura il cult Quiz Show targato Redford, vale a dire i film che saranno poi protagonisti agli Oscar 1995 proprio con Le Ali della Libertà. Una combinazione di mancato tempismo, sfida commerciale, rivalità tra major e logiche industriali – rievocativa di quanto accadde nell’estate del 1982 con E.T. – L’extra-terrestre, Blade Runner, La Cosa e TRON e in quella del 1984 con Gremlins, Ghostbusters, Indiana Jones e il Tempio Maledetto – che finì con il condannare il film di Darabont ad un triste destino al botteghino. Le sette nomination agli Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia), tuttavia, gli diedero nuova linfa commerciale, spingendo Columbia e Castle Rock a ridistribuirlo nelle sale tra febbraio e marzo dell’anno successivo: E da quel momento cambiò tutto per Le Ali della Libertà.

A detta di Darabont: «Nessuno aveva sentito parlare de Le Ali della Libertà fino a quel punto, poi, agli Oscar, fu menzionato il suo nome per ben sette volte». La Warner Bros, con una mossa a sorpresa, si aggiudicò i diritti commerciali per la distribuzione per i canali secondari ordinando la realizzazione di 320.000 copie di VHS. Il risultato? Le Ali della Libertà divenne il film più noleggiato dell’anno grazie al passaparola e ai feedback positivi. Il resto lo fece il destino. Nello specifico la Turner Broadcasting System che dopo aver acquisito la Castle Rock Entertainment nel 1993, poté distribuire il film via cavo a un costo molto basso. Nonostante fosse un candidato agli Oscar a pieno titolo, i bassi incassi permisero a Ted Turner di poterlo acquistare a prezzo di saldo. Divenne rapidamente un fenomeno di culto.

E nacque da un gesto di amicizia Le Ali della Libertà. King, infatti, vendette i diritti del suo racconto per la cifra di 5.000 dollari a Darabont. I due divennero amici quando il regista lo contattò, nel 1983, per adattare il racconto di La donna nella stanza (parte della raccolta A volte ritornano di due anni prima) in un cortometraggio all’epoca molto apprezzato tra gli addetti ai lavori. Fu, tra l’altro, l’inizio del Dollar Baby/Dollar Deal, ovvero, della politica di King di dare in licenza i diritti di utilizzazione economica dei suoi racconti brevi al prezzo di 1 dollaro. Il risultato colpì talmente King da rimanere in contatto con Darabont. Un rapporto di corrispondenza che divenne amicizia fatta e finita quando i due si incontrarono per parlare dell’adattamento di Le Ali della Libertà.

Ciò che lo incuriosì era capire come sarebbe potuto diventare un lungometraggio un racconto incentrato per la gran parte su Red che contempla Andy, il suo compagno di prigionia. Le idee di Darabont per Le Ali della Libertà gli piacquero talmente da decidere di non incassare mai l’assegno da 5.000 dollari. Lo incorniciò e glielo restituì con una nota in allegato: «Nel caso in cui avessi bisogno di soldi per la cauzione. Con affetto, Steve». Cinque anni dopo, nel giro di otto settimane Darabont redasse uno script che parte dalla base kinghiana eccellente per districarsi tra dichiarate suggestioni fantastiche del cinema di Frank Capra (Mr. Smith vola a Washington e La Vita è Meravigliosa) e prison movie leggendari come L’uomo di Alcatraz di John Frankenheimer del 1962. Citato non a caso visto che Frankenheimer fu per davvero coinvolto nel processo creativo.

Durante il location scouting del film televisivo HBO The Prison i due si incontrarono più volte per ispirarsi a vicenda. Il risultato fu una narrazione profondamente umana, drammatica ma ricca di speranza, che vide Darabont ampliare, dischiudere e manipolare all’occorrenza i momenti del racconto kinghiano procedendo per archi narrativi che scorrono sottotraccia per poi esplodere in tutta la loro potenza emotiva. L’amicizia tra Red e Andy diventa il pretesto per raccontare delle vite degli uomini di Shawshank. Del cattivissimo direttore Samuel Norton (Bob Gunton) e la sua brama di potere, delle Sorelle capitanate dal sadico stupratore Bogs Diamond (Mark Rolston) e del capitano Hadley (Clancy Brown). Ma c’è anche tempo per i buoni e le vite di Skeet (Larry Brandenburg), Tommy (Gil Bellows), Floyd (Brian Libby), Heywood (William Sadler) e per il tragico arco di Brooks (James Whitmore), condannato dalla paura e da una vita riformata.

Perché Le Ali della Libertà (in streaming su NOWtv, Prime Video, Apple TV+) ci racconta, si, di fare tutto ciò che è necessario per vivere, di salvezza e della ricerca di bellezza anche negli angoli più oscuri, ma anche del sopravvivere. Come ogni prison movie di peso, quello di Darabont è uno stato d’accusa impietoso verso l’incapacità riformativa del sistema carcerario che sceglie la violenza e la privazione all’umanità e alla dignità preservata. In questo gioca un ruolo decisivo la forbice di valore – e di eventi – tra la scarcerazione di Brooks e quella di Red e la differenza che c’è tra vivere e morire: «Per quarant’anni ho chiesto il permesso per pisciare. È terribile vivere nella paura. Brooks Hatley lo sapeva. Lo sapeva anche troppo bene. Io voglio solo tornare dove le cose hanno un senso, dove non devo avere paura tutto il tempo».

Trent’anni dopo lo si può dire senza timore di smentita: Le Ali della Libertà è il capolavoro di Darabont. Autore che nella sua breve carriera da regista – eccetto il fallimentare ma ispirato The Majestic con un bravo Jim Carrey – si è praticamente occupato solo di adattamenti kinghiani (gli altri Il Miglio Verde e The Mist). Ironia del destino volle però come, da principio, il copione di Le Ali della Libertà fosse semplicemente uno spec-script. La sua idea era quella di segnalarsi come sceneggiatore valido per provare a dirigere un horror grezzo in stile La Bambola Assassina così da districarsi dai lavori precedenti. Prima di allora, infatti, aveva firmato gli script di Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, Blob – Il Fluido che Uccide e La Mosca II. Voleva il suo horror, non solo metterlo su carta per qualcun altro, ma fu Hollywood a decidere per lui.

La Glotzer pur di mettere in cantiere Le Ali della Libertà minacciò di licenziarsi. Rob Reiner, co-fondatore di Castle Rock – e in passato regista di un altro grande adattamento kinghiano (Stand By Me – Ricordo di un Estate) – fu talmente colpito dallo script da offrire a Darabont 3 milioni di dollari per acquistarlo e per poterlo dirigere. Ci credeva talmente da avere strappato un pre-accordo per quelli che con lui in cabina di regia sarebbero stati Andy e Red, ovvero Tom Cruise ed Harrison Ford, ma Darabont disse di no. Considerò seriamente l’offerta di Reiner, ma di riflesso capì come: «Quella era la mia occasione per fare qualcosa di veramente grandioso». Divenne il suo esordio e pur di dirigerlo accettò un taglio allo stipendio in modo da venire incontro alla Castle Rock: 750.000 dollari in tutto più una percentuale sugli utili netti.

La pre-produzione fu qualcosa di leggendario: tutti a Hollywood volevano essere Andy e Red. Charlie Sheen, in particolare, si propose di girarlo al minimo sindacale e girò di suo pugno un test reel per dimostrare di essere un perfetto Red. La Castle Rock disse di no, scegliendo invece Freeman. Nonostante nel romanzo kinghiano fosse un bianco irlandese, Glotzer e Darabont – complice anche il ruolo piccolo-ma-grande nel prison drama Brubaker – vedevano in lui l’unico e solo Red. «Recitare la parte di qualcuno che è incarcerato non richiede alcuna conoscenza specifica della carcerazione, perché gli uomini non cambiano. Una volta che sei in quella situazione, ti limiti a seguire la linea che devi seguire» commentò Freeman al riguardo. Per Andy si fecero invece i nomi di Kevin Costner, Robert Duvall, Gene Hackman, Clint Eastwood e Johnny Depp.

Perfino Tom Hanks, che rifiutò la parte per Forrest Gump e che con Darabont lavorerà poi ne Il Miglio Verde. Infine proprio Tim Robbins di cui Darabont lodò la performance fragile e disperata in Allucinazione Perversa. La lavorazione fu (molto) tormentata. Sei giorni alla settimana e diciotto ore al giorno di riprese estenuanti così commentate da Freeman: «La maggior parte delle volte, la tensione era tra il cast e il regista. Ricordo di aver avuto un brutto momento con il regista, ne ho avuti alcuni, c’era un’atmosfera strana, carica di tensione». Probabilmente a causa del fatto che Darabont sentiva – e parecchio – la responsabilità di un esordio simile. «Un regista ha davvero bisogno di avere un barometro interno per misurare ciò di cui un dato attore ha bisogno» dirà della lavorazione. Problemi che sfociarono nella gestione del finale perché la Glotzer e Darabont la vedevano in maniera opposta.

Nelle intenzioni di Darabont avremmo visto finire Le Ali della Libertà con Red a bordo del bus, verso il confine Casabella. Si sarebbe diretto verso di lui, verso Andy, ma voleva che fosse ambiguo il suo destino. Lo avrebbe rivisto davvero? Sarebbero riusciti a rincontrarsi? Tutto ciò che avremmo visto sarebbe stato soltanto il campo lungo di un bus in lontananza, sperando per il meglio. Nulla a che vedere con ciò che la Glotzer – e la Castle Rock con lei – aveva pensato per il finale. Non c’è bisogno di essere ambigui: Red e Andy si sarebbero riuniti a Zihuatanejo. Una scelta che Darabont ritenne commerciale e sdolcinata, ma che la Glotzer credeva fosse ciò che il pubblico avrebbe voluto vedere dopo tanta attesa. Rispettò comunque la scelta di Darabont a cui garantì il first cut privilege sul montato definitivo.

E così è stato. Darabont si convinse. Inserire quella sequenza avrebbe giovato al Le Ali della Libertà come prodotto filmico finito: «Penso che sia un luogo magico ed edificante per arrivare alla fine della loro lunga saga…». Al punto che in origine la sequenza di Zihuatanejo sarebbe dovuta essere ancora più lunga e non interrotta in panoramica sul più bello, ma poco importa. Ciò che conta davvero sono le ultime parole del lungo racconto per voce di Red, parole che sanno di speranza, sogno e vita e che lasciano allo spettatore la sensazione di aver visto qualcosa che è molto più che un semplice lungometraggio da Oscar. Un grande film sulle cose che contano per davvero nella vita: «Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero».
- LONGFORM | Forrest Gump, Tom Hanks e i trent’anni di un capolavoro
- LONGFORM | Pulp Fiction, trent’anni dopo
- VIDEO | Qui per il trailer di Le Ali della Libertà:

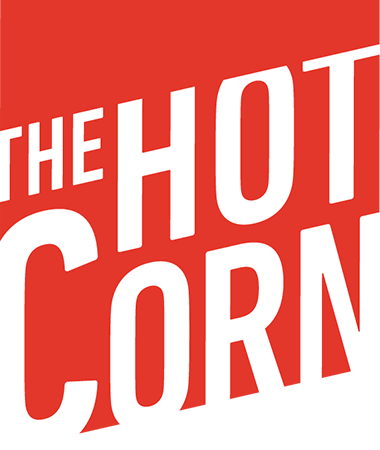



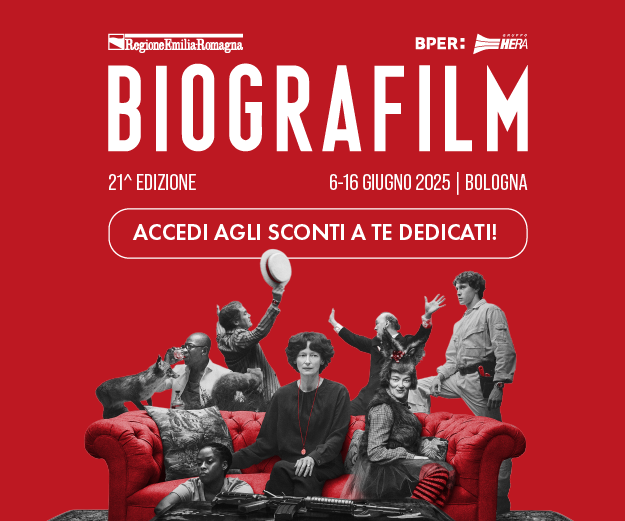


Lascia un Commento