ROMA – «Shane, torna indietro!». Questa è la battuta iconica e leggendaria che viene subito in mente parlando de Il cavaliere della valle solitaria di George Stevens e non soltanto perché pose i sigilli su di un’opera formidabile al sapore di cinema glorioso e classico. Una fiaba vestita di western mitizzante la carica valoriale del buon agire comune americano in funzione di una frontiera non più rincorsa e cercata come agli albori dei western di John Ford (Sfida infernale ne è un esempio perfetto) ma stabilizzata, un luogo dove poter crescere e progredire. Ma quella frase è anche la frase finale di quell’ultimo scambio dialogico, quello dell’ultimo atto tra l’eroe dal volto buono, gli occhi gentili e la pistola veloce Shane (Alan Ladd) e il piccolo Joey Starrett (Brandon deWilde, all’esordio) la cui dinamica relazionale è il cuore narrativo pulsante de Il cavaliere della valle solitaria.

Del resto è proprio questo aspetto de Il cavaliere della valle solitaria che va a inglobare del tutto apertura e chiusura di racconto. Se però nell’incipit vediamo un raffinato campo/controcampo tra la profondità di campo di una verde vallata tinta di blu e un primissimo piano di Joey per poi introdurre Shane nel territorio degli Starrett e la loro causa salvifica, è nel climax che l’opera di Stevens si avvolge del mito dell’immortalità cinematografica. Perché Shane sgomina i prepotenti Ryker e i loro propositi di conquista, sconfigge la nemesi Jack Wilson (Jack Palance) per poi – ferito mortalmente – ripartire a cavallo in campo lungo («Andrò molto lontano. Un uomo ha la sua via tracciata: non può cambiarla») verso il tramonto di un ultimo sole con la consapevolezza che «La tranquillità è tornata nella vallata». Un finale di grande impatto emotivo che regala ai posteri un grande addio cinematografico.
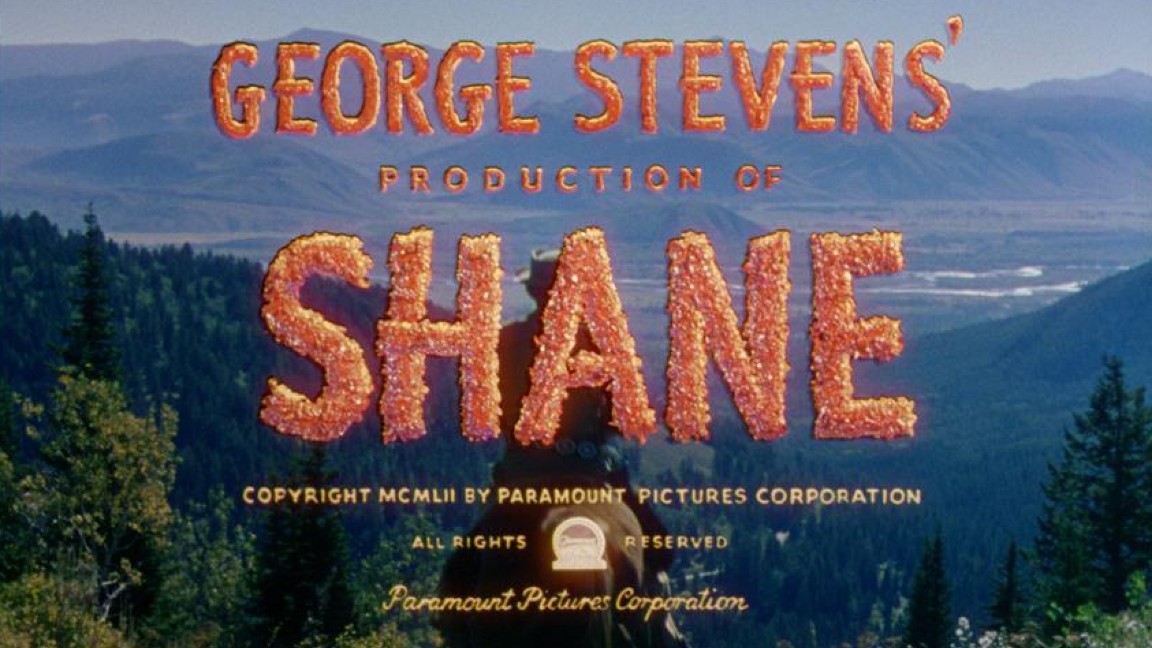
Perché a differenza del triste fato di Shane, non tramonta il fascino de Il cavaliere della valle solitaria. Oggi come ieri (fu presentato a New York il 28 aprile 1953) anche settant’anni dopo, l’opera di Stevens, a detta della tagline formulata in occasione del cinquantennale dalla Paramount – «La più grande storia del West mai filmata» – vive di un solido e inscalfibile retaggio popolato di citazioni e omaggi. Due su tutti: Il cavaliere pallido di Clint Eastwood del 1985, che dell’opera di Stevens è una celebrazione vestita da remake indiretto, e Logan – The Wolverine di James Mangold del 2017 che si serve del concept di Stevens, dei suoi sapori e dei suoi odori filmici, per vestire la narrazione crepuscolare dell’eccellente mutante degli X-Men reso mito da Hugh Jackman, di un cinema d’altri tempi in bilico tra passato e presente, tradizione e innovazione. Facciamo un passo indietro però.

Proprio come il celebre e iconico climax che cova al suo interno uno spassoso aneddoto riguardante il giovane deWilde/Joey incapace di prendere seriamente le emotive parole d’addio di uno Shane/Ladd che, all’ennesima risata e giunti al quinto ciak mandato in fumo, disse al padre: «Fallo smettere o lo picchio in testa!», ce ne sono di storie grandiose intorno alla realizzazione de Il cavaliere della valle solitaria (su Prime Video e Apple TV+) una su tutte la genesi creativa. Perché l’opera originaria da cui è tratto – Shane di Jack Schaefer del 1949 – pur non avendolo mai dichiarato esplicitamente, sembrerebbe aver tratto ispirazione nelle sue vicende letterarie (e poi cinematografiche) dalla celeberrima Johnson County War del 1982 nel raccontare dell’archetipo del conflitto tra allevatori e proprietari terrieri: la stessa, ben inciso, di cui il geniale Michael Cimino vorrà raccontare tra le impareggiabili inerzie filmiche del suo I cancelli del cielo.

Fu talmente un successo letterario Shane che la Paramount ne acquistò i diritti di utilizzazione cinematografica in un battito di ciglia nel 1949. Parallelamente il quasi diciottenne George Stevens Jr. ebbe modo di leggere l’opera di Schaefer durante la sua prima estate al college per poi consigliare al padre: «Potrebbe venirne fuori un grande film!». Ci vide bene il futuro executive dalla carriera gloriosa perché, poco dopo l’annuncio che vide Stevens alla regia del progetto Paramount Il cavaliere della valle solitaria, il collega Howard Hawks gli suggerì la penna da Pulitzer A.B. Guthrie – che con Hawks collaborò per la resa su carta de Il grande cielo del 1952 – come sceneggiatore pur non essendo propriamente uno sceneggiatore di professione. Girato in appena 75 giorni e con un budget da 1 milione e mezzo (ne guadagnerà 9 in tutto il mondo) ebbe dalla sua una post-produzione travagliata.

Nei piani originali della Paramount, infatti, Il cavaliere della valle solitaria sarebbe dovuto uscire nell’ottobre del 1951, ancor prima di Mezzogiorno di fuoco per intenderci. L’ingente mole di pellicola filmata da Stevens, però, portò a una sessione di montaggio quasi eterna che, oltre a far slittare l’uscita delle sale nel film all’agosto 1953, fece aumentare sensibilmente i costi di quello che sarebbe dovuto essere – in termini economici oltre che intenzionali-narrativi – un western semplice e diretto. A un certo punto sembrava che la Paramount volesse perfino cedere la produzione del film a Howard Hughes, e sarebbe perfino andata così se – dopo una proiezione di prova con una copia di lavorazione dal montaggio preliminare – non avesse cambiato idea bollandolo come b-movie, quello che per poco non fece la Paramount che alla fine si trovò costretta a puntarci: sarà un successo!

Perché è un western insolito e gentile Il cavaliere della valle solitaria dove, pur a fronte del suo essere un’opera dal ritmo graduato e caratterizzata da duelli poco spettacolari e macchinosi, privi di alcun mordente, ma di grande impatto nel raccontare quella che Stevens definiva: «L’orrore della violenza». Non solo, anche nell’enfatizzare ogni colpo di pistola mortale: «Quando Jack Palance sparò ad Elisha Cook Jr., in quel film le cose iniziarono a cambiare nei western» disse Sam Peckinpah al riguardo. Il film vive di una solidità registica e di un’umanità impareggiabili. Grande merito, manco a dirlo, all’anomalia Shane resa dal volto e corpo di Alan Ladd per cui, in origine, Stevens aveva immaginato uno fra Montgomery Clift e William Holden, poi l’intuizione. Chiese all’executive Y. Frank Freeman una lista di candidati al ruolo. Avute le foto ci mise appena tre minuti a scegliere il suo Shane.

Già sotto contratto con la Paramount per cui percepì un ingaggio di 145.000 dollari per appena dieci settimane di lavoro (Jack Palance ne prese 12.500) eppure fu ritenuta una scelta anomala Ladd. Alto appena 170 cm, fisico asciutto, a disagio con le pistole (la scena in cui insegna a Joey a sparare dovette essere ripetuta 119 volte) tanto da sparare sempre a occhi chiusi e poco apprezzato da Schaefer che dalla sua lo ritenne: «Un piccoletto. Shane doveva essere un personaggio oscuro e mortale, mi sarebbe piaciuto potesse interpretarlo George Raft». Settant’anni dopo si può ben dire essere la spietata gentilezza di Ladd una delle ragioni del successo senza tempo de Il cavaliere della valle solitaria: una mosca bianca in un panorama di eroi grandiosi e grintosi come i Wayne e Cooper del suo tempo. Un’ultima curiosità riguarda Jean Arthur.

All’epoca cinquantenne e quasi del tutto ritiratasi dalla vita d’attrice tornò al cinema per volere di Stevens da sempre estimatore del suo fulgido talento che la diresse in precedenza in Un evaso ha bussato alla porta del 1942 (dove divise la scena con il sempre-perfetto Cary Grant) e in Molta brigata, vita beata dell’anno successivo per cui ricevette la sua prima e unica nomination agli Oscar. Fu il suo primo ruolo in cinque anni quello di Marian Starrett ne Il cavaliere della valle solitaria dopo aver preso parte come protagonista al wilderiano Scandalo internazionale per un ultimo guizzo memorabile di puro talento. Di lì in avanti sarà solo piccolo schermo tra una guest in Gunsmoke e il dimenticato The Jean Arthur Show a metà degli anni sessanta, ma quella è tutta un’altra storia…
- WESTCORN | Sfida Infernale, John Ford e il mito di Wyatt Earp
- WESTCORN | Romantico Avventuriero, settantacinque anni dopo
- LONGFORM | Il Gigante, Stevens e l’assenza di James Dean
- WESTCORN | Mezzogiorno di fuoco, Gary Cooper e l’anti-maccartismo
Qui sotto potete vedere il trailer del film:








Lascia un Commento