ROMA – Nel bel mezzo dell’assurdo, quando la piega pulp, sboccata e violenta era già tendente al capolavoro, Vincent e Jules – gli stropicciati e leggendari John Travolta e Samule L. Jackson – arrivano a casa di Jimmie Dimmick, con la macchina fradicia di sangue e un cadavere nel bagagliaio. È mattina a Los Angeles e Bonnie, la moglie di Jimmie, sta per tornare dal turno di notte: bisogna far presto, il problema è grosso, c’è un corpo da far sparire. Ma, prima, in una calma solo apparente, nel gioco di cinema dipinto da Quentin Tarantino, c’è ancora il tempo di sorseggiare un caffè. «Che non ha nulla a che vedere con quello solubile. È roba da buongustai», dice Jules. E Jimmy, interpretato da Tarantino, ci tiene a controbattere, seccato: «Sono io che lo compro e so quanto è buono. Quando è Bonnie a fare la spesa compra delle cagate. Io compro sempre roba costosa, perché quando la bevo voglio gustarla!».

Il resto è storia, arriva quel mito di Mr. Wolf – Harvey Keitel, che fuoriclasse -, risolve la matassa e si beve una tazza del buon caffè comprato da Jimmie, rigorosamente con molta panna e molto zucchero. Una scena, delle tante ed eccezionali di Pulp Fiction, capace di racchiudere tutto il senso (o il non-senso) del film, che ha fatto impazzire, sulle note twist di Chuck Berry, l’intera platea di Cannes nel 1994, con un impatto sociologico, cinematografico, narrativo in grado di stravolgere le regole grammaticali della Settima Arte. Un manuale di sceneggiatura (Oscar, non a caso, a Tarantino e Roger Avary), di regia e di cognizione del tempo, che ignora la cronologia per spezzettare la storia in tre episodi avvicendati tra loro, alternando turpiloquio, hamburger, sangue, una valigetta passata di mano in mano, gare di ballo, overdose scongiurate, personaggi sporchi e disperati, dinner, orologi, katane, cure medievali e, appunto, tanto odore di caffè.

Tarantino, già regista prodigio con l’esordio chiamato Le Iene, in Pulp Fiction da rookie di talento diventò ben presto il profeta di un nuovo cinema, citazionista e sclerato, cucito su misura per i cinefili da un cinefilo come loro, nato e cresciuto a pane e VHS. Il pubblico lo ha immediatamente adorato – e l’etichetta cult arrivò puntuale –, con una critica rimasta a bocca aperta: controverso? Sicuramente. Violento? Ovvio. Ineguagliabile? Naturalmente. Il riassunto lo diede il critico Roger Erbert che, allora, lo definì, per innovazione e carisma, il nuovo Quarto Potere.

E non si sbagliava, dato che Pulp Fiction è miscela purissima di postmodernismo, realizzato in modo artigianale nonostante la produzione della Miramax, a supporto di un cast corale oliato e perfetto: i citati Samuel L. Jackson e John Travolta, una stella nascente con il nome di Uma Thurman, Tim Roth e Amanda Plummer, Ving Rhames e, soprattutto, con quel Bruce Willis in canotta e naso rotto, in sella ad una moto (ehm, un chopper), tornato dalla sua piccola prima che potesse dire «Crostata di Mirtilli».

E quegli elementi, dicevamo, che hanno costruito le fondamenta. Dettagli? Sfumature? Connessioni? Diremmo protagonisti: la valigia (espediente, MacGuffin) di Marsellus Wallace contenente chissà cosa (e quanti fan si sono sbizzarriti nell’immaginare cosa nascondesse), l’epica colonna sonora – da Al Green a Dusty Springfield, fino agli Urge Overkill –, e proprio quel caffè, bevuto come fosse benzina per un motore di una fiammante fuori serie, in un’accelerata di 2 ore e 34 minuti (la versione ufficiale) che hanno cambiato il cinema e la sua platea. Provate a rivederlo, a ricominciarlo dalla fine o dall’inizio: cambiare canale è impossibile. «Ma quando lo fai, lo fai zitto e quieto: sei pronto?»









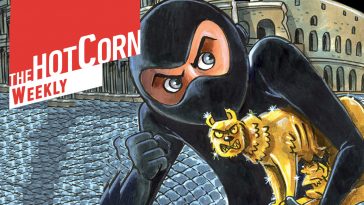




Lascia un Commento