MILANO – Ripartiamo con il nostro viaggio nel mondo western con la nostra amata rubrica West Corn (qui trovate le altre puntate), andando nel 1968. Due anni dopo il successo di Django e Navajo Joe – film che Burt Reynolds trovò inguardabile, ma che in realtà è un film di cui prima o poi dovremmo parlare – ecco che Sergio Corbucci ci regala un formidabile spaghetti western ambientato sulla neve, ultimo lavoro di genere ambientato negli Usa, prima di passare a quelli inseriti nel contesto della rivoluzione messicana. Nonostante l’ambientazione, Il grande silenzio è un film europeo, senza nessun attore americano, cosa che lo differenzia a livello produttivo da Sergio Leone (che in quello stesso anno uscirà con C’era una volta il West). Tra i protagonisti, infatti, spiccano un enigmatico Jean-Luis Trintignant (una novità assoluta la sua partecipazione a questo genere) e il folle, bravissimo, Klaus Kinski, non ancora giunto alla fama tramite Werner Herzog, ma fresco della sua ottima prova in Quien Sabe? di Damiano Damiani (altro protagonista di West Corn qui).

Il grande silenzio è ambientato nel villaggio di Snow Hill, nello Utah, completamente isolato dalle nevi durante il drammatico e rigidissimo Grande inverno del 1898 (non 1896, come indica la trama di Prime Video, dove potete vedere il film in streaming). Lì, ha fatto base uno spietato branco di cacciatori di teste, il cui leader è il carismatico Tigrero (Klaus Kinski), che ha trovato la fortuna nel villaggio grazie ad uno scambio di favori con il corrotto giudice Pollycut (Luigi Pistilli). Il sistema è tanto efficace e semplice quanto brutale e disumano: non ve lo raccontiamo perché emerge nei primi quaranta minuti di film, ed è gustoso scoprirlo. Sappiate che ha a che fare con i meccanismi di stampo animalesco e mafioso-feudale con cui Corbucci contribuisce a decostruire la mitologia del West in pieno stile spaghetti, ma con l’aggiunta di una veracità che va oltre la disillusione autocompiaciuta del sergioleonismo, arrivando a toccare note che suggeriscono un approccio più cinico-pessimistico (vedasi, per esempio, l’inaspettato finale).

Il Silenzio (sì, con la S maiuscola) che compare nel titolo, è l’eroe protagonista, soprannominato così perché «dopo che è passato lui, resta solo il silenzio», ma anche perché è effettivamente affetto da mutismo, questa volta non per scelta di stile come nei personaggi di silenziosi e misteriosi di Clint Eastwood, ma a causa di un evento tragico di cui è stato suo malgrado protagonista da bambino. La menomazione fisica – un elemento tipico in Corbucci, da Django a Minnesota Clay – serve al regista non solo per naturalizzare l’eroe protagonista eliminando l’equivalenza tra perfezione fisica e morale presente nel genere classico, ma anche per enfatizzare la crudezza del mondo nel West, un luogo e un tempo ormai qui pienamente demitizzato, in cui sono le pulsioni umane e i desideri istintuali (come vendetta e risentimento) a guidare i personaggi, perfino quelli considerati tradizionalmente buoni.

E il Silenzio interpretato da Trintignant è certamente un buono, nell’economia del film. Un pistolero venuto da lontano, da solo, un uomo nuovo e civile, moderno anche nella tecnologia visto che impugna una Mauser semiautomatica prodotta in Germania nel 1896, non le solite Colt o Revolver. Non solo: si fa anche portatore di valori nuovi. Non uccide i suoi avversari, ma fa loro saltare i pollici in modo che non possano più sparare (altro elemento di menomazione); oppure, se proprio non può fare a meno di ucciderli, almeno aspetta che siano loro ad aggredirlo per primi, avvalendosi in risposta della legittima difesa. Corbucci sembra suggerire che l’illuminismo europeo (pistola tedesca, attore francese), arrivi per la prima volta per mezzo di Silenzio nelle remote montagne dello Utah, ancora condannate al tardivo e violento Medioevo americano che a suo avviso è stata la storia (vera) del far west.

Il silenzio presente in questo film (questa volta minuscolo) è quindi anche questo: quello che per tanto tempo, secondo Corbucci, il Cinema e la Storia hanno esercitato nei confronti di realtà come quella di Snow Hill, perché se la storia è di fiction, gli eventi e i massacri a cui si ispira appartengono a fatti davvero avvenuti. Anche nel 1898, quando storicamente il West stava ormai diventando un ricordo e nelle città si sentivano frasi del tipo «il vecchio west è finito, sceriffo, ora pistoleri e bounty killer lavoreranno insieme in un vero esercito» (lo dice il governatore allo sceriffo in una delle prima sequenze del film), in realtà la violenza era tutt’altro che istituzionalizzata, continuando ad essere esercitata da uomini che continuavano a considerare la legge costituita come un’orpello per i deboli e gli stolti, mentre «l’unica vera legge è la legge del più forte»,come ricorda Tigrero allo sceriffo. In questo modo, superando le nevi e togliendo dall’oblio questi eventi, Silenzio diventa l’occhio di un antropologo che va a scovare i segreti nel mal compreso rapporto civiltà-west e il film, pur restando dentro il genere western, assume alcuni tratti del film di denuncia (è di pochi anni prima il Leone d’Oro consegnato a Rosi per Mani sulla città).

Certo, il protagonista è sostanzialmente in quei luoghi per realizzare la sua vendetta, perché il motore della sua azione è quello: lui in fondo è un uomo normale, non è un semi-dio come il John Wayne di Sentieri Selvaggi (che avevamo analizzato qui). Eppure la sua vendetta ha come fine l’eliminazione di un nemico che non è colpevole solo nel loro affare privato: in questo grande inverno, sta soggiogando la popolazione di un villaggio e la vendetta del nostro pistolero gentile, allora, si trova a coincidere con la liberazione di un popolo piegato e condannato alla legge del più forte. Ed è così che l’uomo normale, seppur dai modi moderni e civili, diventa agli occhi degli sventurati abitanti di Snow Hill un eroe. Ma quando da semplici vendicatori (o antropologi, o pistoleri a cui hanno tagliato la lingua) ci si trasforma in eroi – ci rammenta il cinico Corbucci- la vita diventa dura, perché non esistono eroi vincenti. L’eroismo non sta nella vittoria o nel conseguimento di un risultato, ma nel contenuto morale che spinge l’eroe a combattere e, nella maggior parte dei casi, a sacrificarsi. Nella realtà, peraltro, il contributo dell’eroe è spesso di pura testimonianza simbolica, ma assolutamente nullo nell’effetto del cambiare le cose: «Non si può combattere da soli contro la violenza». Non esistono casi in cui chi ci prova, non finisca per venirne travolto.

Il grande silenzio è anche un’opera che Quentin Tarantino oltre ad amare follemente, ha anche omaggiato sia in Kill Bill Vol. 1 (la musica di Luis Bacalov, The Grand Duel, venne presa proprio da qui) che saccheggiato palesemente in The Hateful Eight (la diligenza nella neve viene da qui). Eppure qui, come vedrete, Sergio Corbucci non intende giudicare il suo eroe, anzi, sembra suggerire che non avrebbe potuto agire diversamente, perché di fronte a certi avvenimenti l’uomo civile occidentale e post-illuminista è obbligato ad agire. Costi quel che costi. La funzione di quel finale così sorprendente e duro (i produttori costrinsero lo staff a girare altri finali alternativi) è ribadire che non sono gli eroi a spiegare i processi storici, ma il sacrificio dei loro protagonisti, in questo caso le vittime dei massacri della seconda metà degli anni Novanta dell’Ottocento americano, che – come ci spiegano i titolo di coda – aiutarono a far luce sulla natura del problema dei bounty killer e che hanno permesso la transizione alla civiltà.
- WEST CORN | Quando il cinema incontra il West
- VIDEO | Qui il trailer de Il grande silenzio:

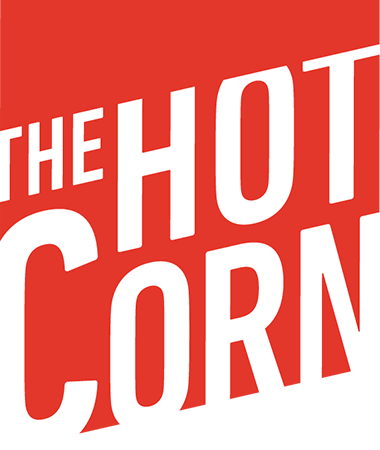






Lascia un Commento