MILANO – Non solo The Holdovers, in qualche modo, il concetto di solitudine appartiene da sempre alla filmografia di Alexander Payne. Non tanto come vuoto, piuttosto come consapevolezza del singolo rispetto al non sentirsi compreso, al non sentirsi parte di alcun nucleo, o peggio, società, perciò alla ricerca costante e cieca, oltreché sorda, di un riparo, capace di proteggere corpo e anima, preservando entrambi per un futuro auspicabilmente migliore, o se non altro, meno vuoto e spietato del presente dal quale sceglie di fuggire, allontanandosi da tutto e tutti, pur restando. Ciascun personaggio principale o secondario del cinema di Payne è passato per questa fuga, per questa condizione di profonda solitudine, pur percepita in mezzo alla folla, proprio perché incapace d’appartenerle realmente. È stato così per ciascuno di loro, nessuno escluso.

A partire dalla Ruth Stoops (Laura Dern) di La storia di Ruth, donna americana, l’esordio alla regia di Payne, proseguendo per il Jim McAllister (Matthew Broderick) di Election, seguito dal burbero, eppure malinconico, Warren Schmidt (Jack Nicholson) di A proposito di Schimdt, fino all’innamorato e irrimediabilmente solo, Miles Raymond (Paul Giamatti) del nostalgico, Sideways – In viaggio con Jack. Ancora, è stato così per il Matt King (uno straordinario George Clooney) di Paradiso Amaro, padre di famiglia vissuto all’ombra di un tradimento, che pur scontrandosi ferocemente con una delle verità più laceranti, accetta la propria solitudine e così la menzogna, comprendendo la capacità di perdonare, un po’ per il tempo, ormai giunto alla fine e un po’ perché, nonostante il tradimento, l’amore, almeno per una delle due parti, è stato reale.

Giungendo infine al protagonista del road movie più senile, dolce e reale di sempre, ossia il Woody Grant (Bruce Dern, cowboy sul viale del tramonto, non più a cavallo, bensì a bordo di un’utilitaria qualsiasi, che ricerca nella provincia americana più desolante e gretta, il significato profondo del passato e di ciò che da lì a destinato a venire) di Nebraska, e allo sfortunato, scontroso e profondamente solo, Paul Hunham (un Paul Giamatti in stato di grazia), protagonista assoluto di The Holdovers e docente impopolare della Barton Academy, cui viene affidato il compito di supervisionare, prima quattro studenti, ed infine uno solo, costretti a restare nel prestigioso collegio di Barton, durante le vacanze di Natale. Barton però non è Weston, e Paul Hunham non è John Keating, seppur L’attimo fuggente (che vi avevamo raccontato qui) balzi alla mente dello spettatore, fin dalle primissime inquadrature di The Holdovers, per poi svanire lentamente.

Poiché pur trattandosi di un racconto di formazione, proprio come il cult senza tempo di Peter Weir, il film di Payne e David Hemingson, sembra volersi concentrare sempre più sui concetti di identificazione, solitudine, comprensione e genitorialità, allontanandosi ben presto dalla pericolosa somiglianza con il film di Weir. Qui infatti non vi è alcun: «Oh capitano, mio capitano», piuttosto una spassosa, liberatoria e cinica gara di insulti tra l’odiato docente Paul Hunham e il giovane e problematico Angus Tully (che bravo, Dominic Sessa!), colui che resta solo alla Barton per le vacanze di natale, inseguendo dapprima un piano di fuga, ed infine un disperato tentativo di restare.

The Holdovers è su molti aspetti la summa della filmografia di Payne, accogliendo nelle sue due ore e un quarto di durata, dalla sorprendente leggerezza, nonostante i temi trattati, tra i quali, depressione, malattia mentale, disfunzionalità familiare e così via, tutto ciò che della poetica di Payne, da La storia di Ruth, donna americana ad oggi, abbiamo imparato ad osservare e conoscere. Dalla riflessione sull’appartenenza del singolo ad un certo nucleo, a quella sulla genitorialità inevitabilmente complessa e molto spesso traumatica, fino alla dimensione narrativa del road movie, che qui torna, in grande stile, attraverso una spassosa fuga a Boston destinata a mutare in un vero e proprio processo di identificazione, seguito da una profonda comprensione, perciò dall’amore, mai realmente nominato e soltanto suggerito, ad ogni modo, concretissimo.

A scanso di equivoci, seppur ambientato nel corso del periodo natalizio, The Holdovers non è un film da festività, piuttosto un racconto fortemente dolente, malinconico e sussurrato e infine divertente, su coloro che restano e coloro che se ne vanno, e poi ancora, su coloro che pur essendo presenti, non sembrino affatto volersi palesare, lasciando cicatrici indelebili, tanto nella memoria, quanto sul corpo, fino al raggiungimento di una definitiva accettazione della propria solitudine, causata da una feroce impossibilità d’essere amati e osservati per ciò che si è, da qui la rassegnazione e la necessaria costruzione d’una corazza inevitabilmente rude, sprezzante e difficilmente amabile. È la seconda volta dopo Nebraska, scritto da Bob Nelson, che Alexander Payne sceglie di affidarsi ad una sceneggiatura altrui, questa volta ad opera di David Hemingson.

E considerato quel precedente, sembrerebbe essere la via migliore per il cinema di Payne, trattandosi dei suoi due titoli più riusciti, sinceri e memorabili. Curioso poi quanto prema riascoltare Sometimes You Can’t Make It on Your Own – una delle migliori tracce di How to Dismantle an Atomic Bomb degli U2 – appena raggiunta la conclusione di The Holdovers, ritrovando in essa un passaggio, che meglio e più di qualsiasi riflessione scritta e non, sembri racchiudere il senso profondo del film di Payne ed Hemingson: «We fight all the time, You and I…that’s alright. We’re the same soul. I don’t need…I don’t need to hear you say. That if we weren’t so alike. You’d like me a whole lot more». Sulla solitudine e l’identificazione. The Holdovers, una grande lezione di cinema e di scrittura.
- OPINIONI | Paradiso amaro, Clooney, Payne e un piccolo manuale di talento
- LONGFORM | Nebraska, Alexander Payne e il viaggio come ricostruzione
- VIDEO | Qui per il trailer del film

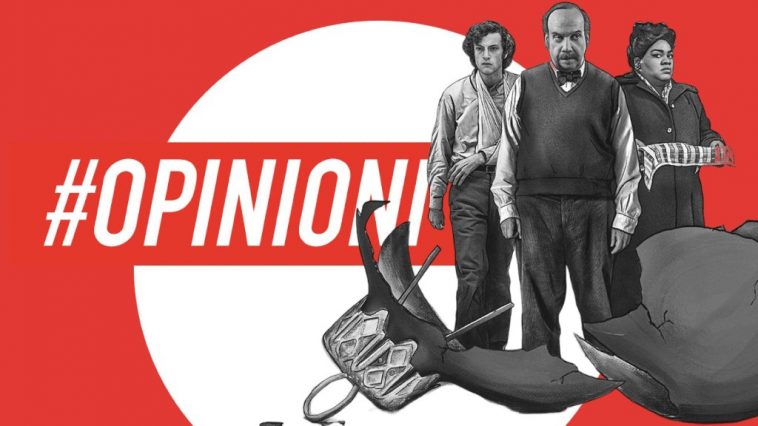




Lascia un Commento