MILANO – Quando Sofia Coppola scrisse la sceneggiatura de Il giardino delle vergini suicide aveva solo ventisette anni. Due anni dopo, nel maggio del 1999, il film avrebbe debuttato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, ma in Italia sarebbe approdato al cinema solo un anno dopo, ovvero il 15 settembre del 2000. Cresciuta all’ombra di un padre come Francis Ford, Sofia era diventata celebre suo malgrado qualche anno prima, nel 1990, per le critiche spietate alla sua interpretazione di Mary Corleone ne Il Padrino – Parte III, un ruolo che era stato pensato per Winona Ryder che disertò all’ultimo momento per un problema di salute. Eppure quell’anno sulla Croisette, Sofia Coppola si prese la rivincita e fece ricredere praticamente tutti con l’adattamento del romanzo di Jeffrey Eugenides, Le Vergini Suicide, pubblicato in Italia nel 1993.

«Quando avevo circa vent’anni, mi sono imbattuta nel libro», spiegò poi la regista in un’intervista. «Non sapevo di voler diventare un regista fino a quando non l’ho letto. Ricordo di aver visto la copertina con solo quei capelli biondi. L’ho adorato. Sembrava che Jeffrey Eugenides comprendesse davvero l’esperienza di essere adolescente: il desiderio, la malinconia, il mistero tra ragazzi e ragazze. Ho amato il modo in cui i ragazzi erano così confusi dalle ragazze, e mi sono sentita connessa a tutto quel crogiolarsi nella propria camera da letto. Non mi sembrava di averlo visto molto nei film, non in un modo in cui mi potessi relazionare. Ho visto la storia come il racconto del modo in cui operano distanza, tempo e memoria, lo straordinario potere dell’insondabile».

Ambientato in un sonnolento quartiere di Grosse Pointe, nel Michigan, nel 1974, Il giardino delle vergini suicide racconta la storia delle sorelle Lisbon, ovvero Therese (Leslie Hayman), Mary (A.J. Cook), Bonnie (Chelse Swain), Lux (Kristen Dunst) e Cecilia (Hanna R. Hall), cinque adolescenti dai capelli color grano cresciute da una madre severa (Kathleen Turner) e un padre dal temperamento molle (James Woods) nella periferia di Detroit. Un’adolescenza sacrificata, asfissiante, fatta di regole e divieti che mostra i primi segni di ribellione nel tentativo di suicidio della più piccola di loro, Cecilia. Una storia della quale ci viene raccontato subito il tragico epilogo dalla voce narrante, rappresentante di quel gruppo di ragazzi del vicinato affascinato e incuriosito da quelle ragazze per loro indecifrabili.

Un’informazione che permette a Eugenides prima, e alla Coppola poi, di indirizzare l’attenzione del racconto altrove, perdendosi nei dettagli della quotidianità delle ragazze. Un’atmosfera fatta di smalti e profumi, vinili dei Kiss e cataloghi di luoghi esotici grazie a cui perdersi tra le strade di Calcutta o tra i templi in Giappone. Prigioniere nella loro stessa casa, inascoltate, le sorelle Lisbon erano «donne travestite che capivano l’amore e la morte», la cui consapevolezza le porterà al gesto più estremo. Così la loro vita diventa un cumulo di se, di possibilità inespresse, di vuoto. Venticinque anni dopo, Il giardino delle vergini suicide rimane un film seminale in cui Coppola ha saputo fotografare la malinconia, lo struggimento ma anche quei riti – solo apparentemente banali – tipici dell’adolescenza con uno stile registico onirico e pop. Ma dietro la patina sognante, la regista ha messo in scena un dramma fatto di incomunicabilità, oppressione sociale e resistenza estrema.

La stessa resistenza che porta le ragazze ad incatenarsi all’albero del giardino di casa, destinato ad essere abbattuto, simbolo – proprio come loro – di vita contro la morte. Un’opera capace di influenzare il cinema successivo – basti pensare alle sorelle protagoniste di Mustang di Deniz Gamze Ergüven – nelle suggestioni come nelle tematiche. A fare da eco la fondamentale colonna sonora degli AIR, eterea come le sorelle Lisbon, per un film in cui le domande rimangono senza risposta. Resta solo il rimpianto di un gruppo di ragazzi che non ne è mai riuscito e risolvere l’enigma dietro quei sorrisi tristi. «Scoprimmo che le ragazze sapevano tutto di noi e che noi non potevamo capirle affatto. Cercammo di dimenticarle, ma ovviamente era impossibile…».

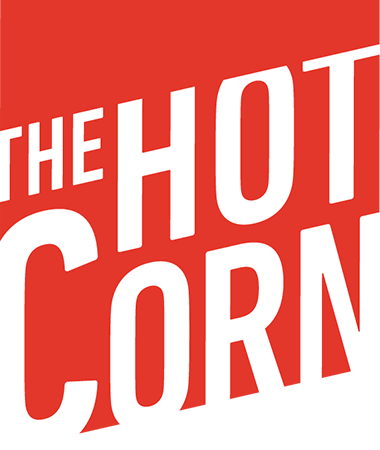



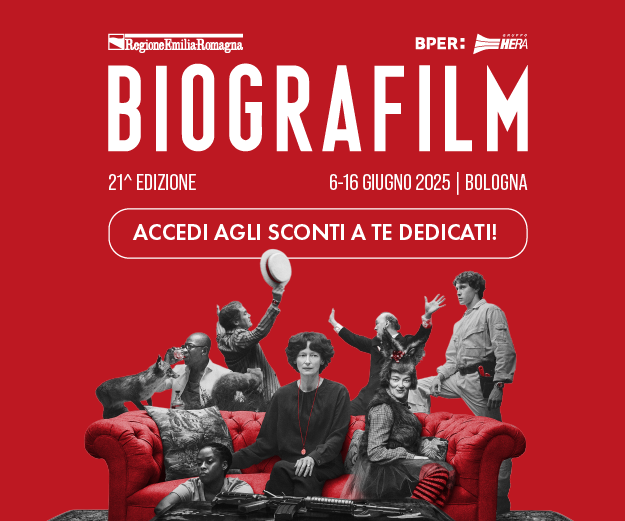


Lascia un Commento