MILANO – Deadwood – Il Film – lo trovate su CHILI –, uscito in sala nel 2019, è sostanzialmente un’operazione nostalgia, in cui rivediamo all’opera dopo 13 anni (quasi) tutti i principali personaggi dell’omonima fortunata serie della HBO le cui tre stagioni sono andate in onda tra il 2004 e il 2006. Dobbiamo subito dire, però, che non si tratta di una pacifica reunion decisa ad una pizzata di vecchie glorie. Anzi, tutt’altro. Perché questa pellicola è il risultato di una vera e propria lotta portata avanti per anni dal regista Daniel Minahan e lo sceneggiatore-ideatore David Milch per continuare a lavorare alla serie. Riassumendo brevemente i fatti: dopo la terza stagione, per motivi legati alla proprietà dei diritti di distribuzione internazionale della serie, HBO mise in discussione la prosecuzione della stessa, sebbene stesse riscuotendo un discreto successo tra il pubblico; allora si cominciò a trattare, inizialmente per una ultima quarta stagione, che poi si tramutò nell’ipotesi di girare due film e, infine, nella scelta di chiudere l’esperienza con questo un unico lungometraggio.

Lo stile è in linea con quello della serie che – ambientata a partire dal 1876 – seguiva il filone del western “mud and rags” (fango e stracci) sull’onda del Kaufman de La banda di Jesse James (1971) e de I cavalieri dalle lunghe ombre (1980) di Walter Hill. Ma ora sono passati diversi anni dai tempi dannati e benedetti della fondazione, e la ex città pioniera di Deadwood (tutt’ora esistente) ha nel 1889 (anno in cui è ambientato il film) ormai triplicato il numero dei suoi abitanti e, con l’inclusione del Sud Dakota come quarantesimo Stato dell’Unione, si appresta a diventare parte integrante degli Stati Uniti d’America.“La festa è finita”, sembra dirci con la sua regia molto televisiva Daniel Minahan (che nel frattempo ha ampliato la propria esperienza girando puntate di House of cards e Il Trono di spade), il quale intreccia abilmente il discorso sulla fine della sua serie, con la fine del west e l’avvento dello Stato di diritto che si consumava proprio in quel passaggio decisivo della Storia del Sud Dakota.

Deadwood – Il Film è un’opera piena di rancore e rimpianto, ricca di flashback a ricordare quanto erano giovani i personaggi e quanto è ormai lontana quell’epoca di libertà, gioco d’azzardo, case di piacere e malaffare; adesso il nuovo mondo incombe, arriva l’elettricità (la vera Deadwood fu una delle prime città ad avere la luce), i fili del telefono rendono più fluide le comunicazioni e, con il progresso, si estende anche il dominio della legge federale e della democrazia costituzionale. E qui arriva il conflitto, perché se la serie sembrava guardare compiaciuta a quel mondo di mezzo che raccontava – e che tanto ricordava le associazioni protettive prestatali e simil mafiose descritte da Nozick in Anarchia, Stato, Utopia – il passaggio allo stadio successivo (la cessione di parte del potere politico al governo federale) viene osteggiato da chi il suo potere se lo era guadagnato con ogni mezzo, forza e fatica nei bei tempi addietro.

E così, sotto lo sguardo carismatico di un vecchio e stanco Al Swearengen (Ian McShane) si affrontano lo sceriffo Bullock (Timothy Olyphant) e il Senatore-imprenditore Hearst (Gerald McRaney). Il primo si fa portatore e garante dell’ordine locale, il suo uso della forza è considerato genuino e legittimo poiché è la risultante di anni di lotte intestine e accordi tra le parti, e da quelle dinamiche deriva, in ossequio al motto “under God people rule”, nato proprio in quegli anni in Sud Dakota, e che assegna i fondamenti metafisici del diritto e del potere alla morale divina, mediata dal consenso del popolo e dal suo naturale istinto etico. Il secondo, delineato come un uomo assetato di potere e di sangue, risulta invece incapace di rappresentare altro dai suoi interessi, ed è l’incarnazione di un potere arrivato da lontano, oscuro, percepito come un imposizione dalla città e da una cittadinanza che non ne capisce l’immediata necessità pratica (e si coalizzerà contro di lui).

Da un lato, insomma, la legge e l’ordine raggiunte secondo il contratto sociale condiviso di Hobbes, dall’altro il sopruso del “diritto del mare” evocato da Carl Schmitt. Ma non è questo il livello su cui valutare il film, perché questa volta il genere western non è al servizio di teorie di filosofia politica, né una allegoria della nostra società contemporanea. La sua grammatica decadente e autoassolutoria (che sta tutta nel personaggio e nel gesto finale di Calamity Jane) è metafora del rapporto tra la serie ed HBO, tra la nostalgia, il rimpianto e la proiezione della colpa. Minahan e Milch non stanno davvero strizzando l’occhio al fascino di quel mondo infernale, né stanno provando a dire che gli Stati Uniti si sarebbero imposti con violenza sulla città di Deadwood (anche se la tentazione populista c’è, ed emerge tutta nella scena dell’aggressione al Senatore sul finale).

Piuttosto, gli autori si dannano per non aver potuto sviluppare tutte le potenzialità narrative che quel mondo privo di leggi e di tabù gli avrebbe concesso, un luogo al riparo dalle convenzioni sociali in cui poter indagare l’animo umano al suo stato primordiale e animalesco. Ma la ricreazione è finita, è così le due Deadwood (città e serie), e tutti i suoi (forse troppi) personaggi – e in questo si vede che la scrittura è più televisivo-seriale che cinematografica -, dopo quest’ultima avventura ad uso interno rivolta ai fan della serie, dovranno consegnarsi. Qualcuno alla Storia, altri alla realtà.







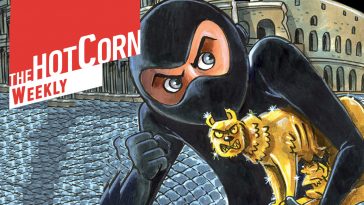




Lascia un Commento