Il 13 giugno del 1971, il New York Times pubblicò per la prima volta una parte dei Pentagon Papers, studio di settemila pagine commissionato qualche anno prima dall’allora Segretario della Difesa, Robert McNamara, per comprendere a fondo le vicende legate ai rapporti tra Stati Uniti e Vietnam. Dentro quelle carte, c’erano informazioni riservatissime – fotocopiate illegalmente da Daniel Ellsberg e Antony Russo a partire dal 1969 – che compromettevano le Amministrazioni Democratiche e Repubblicane che avevano in qualche modo avuto a che fare con il Sud-Est asiatico, ovvero tutte quelle del Dopoguerra: da Truman a Johnson, passando per Eisenhower e John Kennedy. La reazione di Richard Nixon alle pubblicazioni fu senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, perché il Presidente diffidò il New York Times dal pubblicare ulteriori parti di quei documenti, sostenendo che avrebbero potuto essere un pericolo per la nazione.

A questo punto inizia la vicenda centrale del film, con però protagonista un altro quotidiano, il Whasington Post, ai tempi solo un piccolo giornale a tiratura cittadina molto vicino ai democratici che, come apprendiamo dai primi minuti di The Post, viveva tutt’altro che un bel momento e vedeva la sua editrice Kay Graham (un’ottima Meryl Streep) contrattare l’entrata in borsa della testata per salvarla dal disastro finanziario. Il dilemma del Post è semplice: ottenere la pagine di McNamara e continuare la pubblicazione dei documenti iniziata dal New York Times rischiando che i suoi finanziatori si tirino indietro e che Nixon li porti in tribunale? Oppure rinunciare, aspettando che l’ingresso in borsa sia completo e il giornale sia salvo?

Per un sognatore come Steven Spielberg – subito innamoratosi della sceneggiatura di Liz Hannah e Josh Singer, che sembra scritta apposta per lui- la risposta è ovvia, e può venire unicamente dal cuore dei protagonisti, dalla lotta morale e squisitamente hollywoodiana tra la libertà di stampa, il diritto del popolo americano di sapere e un Presidente oscurantista e burbero, chiuso nella sua stanza ovale e convinto che lo Stato sia suo, non dei cittadini. Dal punto di vista cinematografico siamo di fronte a un film di genere, all’ennesimo elogio del quarto potere fatto di integrità e duro lavoro, alla lotta di Davide contro Golia; ma se per Tutti gli uomini del Presidente (con cui questo film, oltre al genere, condivide il periodo storico e il Presidente) Alan J. Pakula aveva scelto un andamento lineare e fondato quasi unicamente sui fatti e i meccanismi che regolarono gli intrecci del Caso Watergate, Spielberg predilige l’aspetto psicologico dei personaggi, soprattutto nella figura della padrona Kay Graham.

Grazie al personaggio della Graham, usciamo dalla pura lotta per la verità – che resta comunque un tema centrale- per addentrarci nella questione circa il ruolo della donna di un’America muscolare e maschilista, nella quale per la prima volta questa signora comprende l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle, con le normali insicurezze che affliggono chi ha vissuto una vita sentendosi dire di non essere all’altezza. E Meryl Streep non poteva esserne interprete migliore, con quella sua ostentata sicurezza di donna di potere, dalla quale traspare una malcelata malinconia e la consapevolezza di essere soltanto un essere umano che non ha ancora capito di che pasta è fatto e sta imparando a distinguere categorie come il coraggio, l’incoscienza, la paura e la giustizia, di fronte ad un bivio in cui potrebbe perdere tutto.

Dal personaggio interpretato da Tom Hanks – direttore del giornale – emerge invece l’aspetto più politico della vicenda: la sua ostinazione, la sua fermezza, il suo senso del dovere, sono un elogio all’America come democrazia, un richiamo esplicito ai padri fondatori e alle prescrizioni costituzionali di una Paese capace di trovare ancora conforto nelle premesse fondanti, a cui Spielberg dà una connotazione quasi mitica. The Post, del resto, è un film di denuncia in cui non è mai presente una critica al sistema in sé, ma in cui anzi il sistema (i contrappesi ai poteri, i giornali, la Corte Suprema) è la soluzione stessa del problema, perché nella sua lettura sono sempre le persone singole ad essere colpevoli, e in particolare quelle persone che vengono meno all’integrità richiesta dal loro ruolo istituzionale e che tramite le sentinelle del potere del giornalismo indipendente vengono ricondotte sulla retta via.







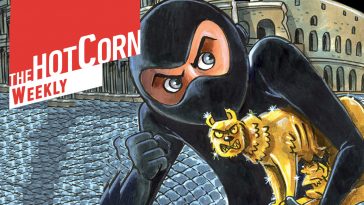




Lascia un Commento