MILANO – Un omaggio meta-testuale in una delle sequenze-chiave di Hot Fuzz, il nomignolo dato da Tony Stark a Thor in Avengers, le iconiche rapine degli ex-Presidenti con maschera e mitra spianato che poi riempirono anche le cronache. Basterebbero anche solo questi tre riferimenti per certificare lo status di cult totale di Point Break – Punto di rottura, diretto da Kathryn Bigelow e uscito in sala trentatré anni fa: il 10 luglio del 1991 negli Stati Uniti, ma il 15 novembre dello stesso anno in Italia. Un’aura magnetica di puro fascino cinematografico che, se la prova del tempo sembra ricondurne le ragioni allo spirituale ma selvaggio Bodhi – il villain portato in scena da Patrick Swayze, monumentale – ad una più attenta analisi pare però partire da ben più lontano. Molto più lontano. Ma da dove esattamente?

Facciamo un passo indietro: prodotto da James Cameron nonché primo vero punto di svolta della stella registica Bigelow dopo i convincenti Il buio s’avvicina e Blue Steel, il racconto di Point Break è apparentemente dei più tipici. Una banda di rapinatori mascherati da ex-Presidenti degli Stati Uniti è la rovina del dipartimento dell’FBI di Los Angeles. Ogni estate infatti assaltano un paio di banche per poi dileguarsi nell’ombra. Chi sono? Da dove vengono? Sulle loro tracce c’è il veterano Angelo Pappas (Gary Busey, l’ex-Leroy Smith del surfistico Un mercoledì da leoni) che ritiene che i rapinatori siano dei surfisti. Nessuno però fa caso alle teorie di Pappas. Nessuno tranne Johnny Utah (Keanu Reeves, un attimo prima di un altro cult, Belli e dannati, che vi abbiamo raccontato qui), novellino di Quantico fresco di primo incarico.

Utah si troverà così ad entrare nella comunità dei surfisti di Los Angeles facendo la conoscenza di Tyler (Lori Petty, rivista di recente in Orange Is the New Black), del carismatico Bodhi (Swayze, appunto) e delle sue idee rivoluzionare. Ben presto però, la pacifica comunità di Bodhi alzerà la maschera e per Utah significherà scegliere da che parte stare. Se seguire la legge o lasciarsi ammaliare dal credo di assoluta libertà del biondo surfista ribelle. Il successo di Point Break (lo trovate in streaming flat su Prime Video) corrisponde, di riflesso, al fallimento il remake del 2015. L’opera di Ericson Core infatti, pur giocando di opposizione morfologica tra i suoi due interpreti, sceglie una chiave di lettura difforme (se non perfino antitetica). Ritroviamo anche qui la medesima dinamica buddy alla base del racconto originale così come sequenze di pura spettacolarizzazione declinate secondo le estetiche del cinema di riferimento.

A mancare però è la profondità dell’originale Point Break. Quell’amalgama impareggiabile di caratterizzazioni colorite, stunt adrenalinici e teorizzazioni sull’onda perfetta che nell’unire la spiritualità del surf ai nobili intenti buddhisti del Bodhisattva (rinuncia del singolo al raggiungimento del Nirvana per la salvezza del collettivo) finisce con il dar sostanza a un racconto dal respiro asciutto tipicamente Bigelow: perfetto punto d’incontro tra tradizione e innovazione. Tra le righe della sua spettacolarità vertiginosa Point Break è solo in apparenza un racconto classico nell’affrontare il buddy cop e le sue tipizzazioni. Lungo il dispiego dell’intreccio infatti la Bigelow ribalta le percezioni caratteriali dei suoi agenti scenici svestendoli del tutto del proprio essere archetipi del più che tipico super-poliziotto o del villain tutto d’un pezzo, rendendoli infine fallibili, umani, veri.

Per dirla con le parole della regista: «Non si tratta di buoni e cattivi. È un po’ più complicato. Quando il tuo bravo ragazzo, il tuo eroe, viene sedotto dall’oscurità che è dentro di lui, il tuo cattivo non è affatto un cattivo; è più un antieroe». Un racconto solido, capace di portare i cops nella loro accezione buddy verso una dimensione nuova. Surf e FBI, azione e filosofia. Narrazioni di puro spettacolo cucite addosso a personaggi non più bidimensionali perché unicamente funzionali al racconto, ma anzi, dotati di archi di trasformazione colorati e (già) iconici con cui innescare sorprendenti riflessioni esistenziali nella dimensione emotivo-empatica dello spettatore. Di lì in avanti la Bigelow realizzerà un’irresistibile ascesa che la porterà, nel 2010, ad essere la prima donna vincitrice dell’Oscar per la regia (The Hurt Locker) in più di ottant’anni di Academy (poi sarebbe arrivata anche Chloé Zhao).

Tutto parte da qui però. Da quel Point Break oggi trentennale (e invecchiato benissimo) che in origine avrebbe dovuto dirigere Ridley Scott salvo poi ripiegare su Thelma & Louise (di cui potete leggere qui). Il film che in piena pre-produzione si intitolava unicamente Johnny Utah esattamente come il nome dell’eroe di Reeves. Più però Cameron e Bigelow lavoravano sullo script tratto dall’idea originale di Rick King, più si rendevano conto di come Johnny Utah avesse davvero poco a che vedere con l’essenza surfistica del racconto che stava diventando altro. Si optò così per il doorsiano (e suggestivo, molto suggestivo) Riders on the Storm, che rimase per qualche settimana, salvo poi essere cestinato perché privo di alcun legame logistico con il mito targato Jim Morrison (attenzione però ai cameo di Anthony Kiedis e Flea dei Red Hot Chili Peppers).

Alla fine delle riprese arrivò finalmente il titolo giusto: il surfisticamente calzante Point Break, ovvero un termine che indica il punto di rottura di quando le onde si rompono in entrambe le direzioni a contatto con un punto di terra o roccioso. Point Break. Il punto di rottura. La perfetta metafora del complesso rapporto tra Johnny Utah e Bodhi: l’uno, il punto di rottura dell’altro, mondi apparentemente in collisione destinati a cambiare per sempre le carriere (e le vite) di ognuno dei suoi protagonisti che non riusciranno più a essere ciò che erano prima. «Se vuoi il massimo, devi essere pronto a pagare il massimo». Vaya con Dios.
- LONGFORM | Keanu, River e il set di Belli e dannati
- LONGFORM | Giuseppe Cederna ricorda Mediterraneo
- VIDEO | Qui il trailer originale:

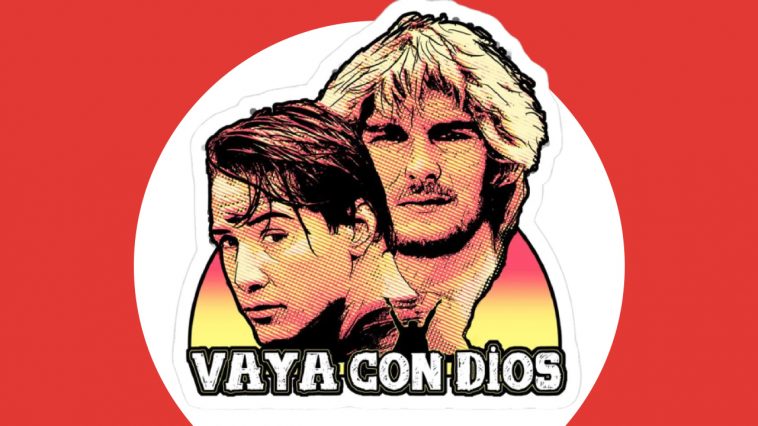




Lascia un Commento